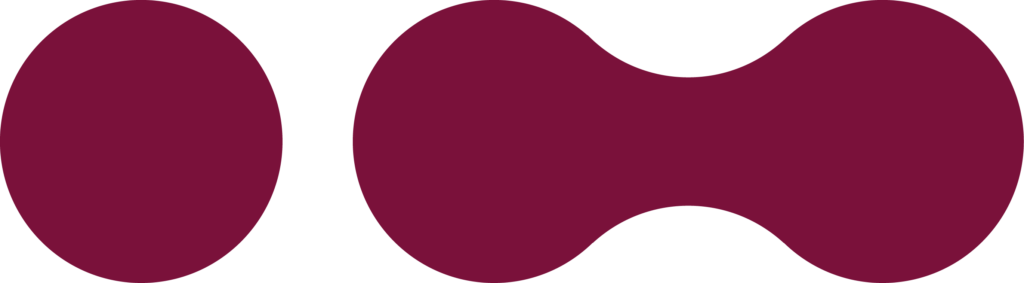Il mondo è entrato in una fase di politica demolitrice. La distruzione radicale – piuttosto che riforme attente e correzioni graduali delle politiche – è all’ordine del giorno. […] Di conseguenza, a più di 80 anni dall’inizio della sua costruzione, l’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra è ora in fase di distruzione.
“Under Destruction”, Munich Security Report, febbraio 2026
Iniziare un documento come questo citando il report della Munich Security Conference (uno dei più importanti forum sulle politiche della sicurezza internazionale, a cui ogni anno partecipano capi di stato, generali, etc.) può risultare straniante, ma è un segno dei tempi e la limpida affermazione di un momento storico che ha dinamiche davvero inedite. Viviamo in uno spartiacque, una linea di separazione tra due periodi storici. Dentro una linea tempestosa.
Con queste riflessioni vorremmo contribuire a un dibattito sulle forme di lotta e le ipotesi politiche sovversive, di parte, autonome, da costruire in questa turbolenza. Con l’ambizione di arrivare a costruire in modo collettivo una proposta politica complessiva, fuori dalle secche della geopolitica, dentro il terreno dei conflitti sociali.
Proviamo a farlo cercando di restituire dei tratti del nostro dibattito a partire da tre sfere di discussione: proponendo alcuni riquadri per interpretare la fase, delle riflessioni sulle forme di azione politica, e alcuni lineamenti su proposte di lotta. Per chiudere con una postilla.
1. Riquadri
Da dove partiamo? Ucraina? Gaza? Sudan? Venezuela? Iran? Groenlandia? Siria? …? Ogni settimana si organizzano presidi per invocare la cessazione delle aggressioni militari. Eppure, troppo spesso, ci si accorge di non aver fatto un centimetro di strada, correndo il rischio di trasformare la militanza in una rappresentazione inefficace. Dall’altra parte della barricata si agisce diversamente, dentro regole del gioco che sono cambiate. Da un lato, le iper-semplificazioni, gli slogan facili, i posizionamenti da comfort zone ideologica, non funzionano. Allo stesso tempo, senza una capacità di tagliare politicamente la complessità, il rischio è l’inazione, lo stare ferme. Dentro questa tensione, dentro una mappa del mondo in velocissima trasformazione, oggi difficile da abitare, proviamo a fissare alcune coordinate generali e alcuni spartiacque, a partire dal fissare un turning point storico: la pandemia planetaria del 2020.
Coordinate della fase:
- Crisi egemonica statunitense: al di là delle diverse letture (crisi dell’unipolarismo o tensioni del multipolarismo), è un’evidenza leggibile tanto nella situazione di pre-guerra civile interna quanto nella proiezione “emisferica” della nuova visione USA.
- Congiuntura di guerra: processi di militarizzazione che si esprimono nella moltiplicazione degli scenari bellici, nell’economia politica del riarmo e nell’inasprimento del disciplinamento sociale.
- Ascesa dell’“Internazionale nera”: una matrice reazionaria comune che, a diverse latitudini, guida o tenta di guidare la nuova fase politica planetaria, adattandosi ai contesti nazionali (Trump, Meloni, Milei, Le Pen, AFD, etc.).
- Tecno-autoritarismo: la torsione della cosiddetta “rivoluzione digitale” dopo la sua fase progressista (neoliberalismo inclusivo della Silicon Valley), dentro un’accelerazione di AI, robotica e piattaforme governata da oligarchie, monopoli e visioni autoritarie che intensificano la polarizzazione economica e sociale.
Questo non è un quadro di “ordine”, né i suoi protagonisti perseguono la stabilità. Scavare politicamente in tale scenario significa cercare contraddizioni, punti deboli delle controparti, zone di rottura, evitando ubriacature ideologiche, automatismi analitici e chiavi di lettura universalizzanti. Il richiamo al “diritto internazionale” nel 2026 è una direzione bizzarra, dopo che la sua parvenza ideologica è stata demolita dallo stesso attore che l’ha storicamente prodotto: gli Stati Uniti, attraverso trent’anni di invasioni “illegali” per quello stesso diritto. Che oggi potenze come Cina o Brasile lo rivendichino è comprensibile e legittimo per loro; la domanda è se noi dobbiamo stare su quel terreno, fino ad adottarne le lenti liberali (società civile, governance, ordine globale). La risposta è evidentemente negativa. Così come la ricerca di un nuovo ordine non è certo il nostro compito. Non sta a noi proporre ricette globali: dobbiamo rifiutare politicamente la chiusura intrinseca alla stagnazione del tutto per rivendicare quella apertura, illimitatezza e movimento del farsi parte. Dobbiamo accogliere ciò che il termine stesso ci impone, e cioè l’incompletezza, la differenza, la contraddizione, rendendoli attributi di forza.
Quello che viviamo è anche un effetto boomerang imperiale. Negli USA, decenni di guerre esterne hanno prodotto una militarizzazione interna che oggi si condensa nell’operato dell’ICE e nelle pratiche di controllo metropolitano di agenti che operano come fossero in “territorio nemico”, senza che questo rappresenti una novità esclusivamente trumpiana. Così come non è certo casuale che Meloni parli delle recenti manifestazioni in Italia come popolate di “nemici della nazione”. Ma l’internazionale nera si muove nelle dinamiche di guerra civile embrionale giocando dentro una forzatura del quadro costituzionale, non nella sua rottura. È sempre stato così: le esperienze reazionarie piegano l’ordine esistente ai loro fini, non lo spezzano. La rottura, storicamente, è stata invece praticata dai movimenti comunisti e dalle lotte di classe: costruzione di altro potere, eccezione reale.
2. Forme di azione
La sollevazione di fine estate/inizio autunno per la Palestina globale ha rappresentato uno spartiacque soggettivo, riportando in campo elementi già presenti nel “decennio delle rivolte” (2010–2020): tratti insorgenti delle mobilitazioni; diffusione virale, tempistica e ritmica “da social media”; enigmi organizzativi; legami spesso invisibili ma reali tra dimensione internazionale e territoriale. Ha riqualificato in modo straordinario cosa significhi oggi “sciopero generale”, ha fatto davvero paura. Allo stesso tempo, è emersa con forza l’impossibilità di garantire una durata a quel sommovimento attraverso “scorciatoie”: né la semplice linearità monotematica del “continuiamo sulla Palestina” (come se si trattasse di costruire campagne “su”, e non invece intrecciare lotte “per” e “con”), né lo spostamento meccanico sull’opposizione al governo o alle politiche di riarmo (necessità vere e urgenti ma che, anche qui, non possono essere generate con manovre eterodirette).
Le persone si mobilitano se percepiscono che la loro azione conta, se incide sui rapporti di forza. In tal senso, anche la scorciatoia elettoralistica – tra frontismo democratico e settarismi di varia natura – non offre risposte credibili davanti alla richiesta di lotta e pretesa. Ma dobbiamo anche dirci che la metodologia della convergenza, pur essendo uno sguardo importante per smarcarsi dal pericolo dell’autoreferenzialismo, ha mostrato limiti strutturali in una fase radicalmente mutata. La risposta nazionale allo sgombero di Askatasuna ha di certo rappresentato una boccata d’aria fresca in tale panorama, coniugando una mobilitazione quantitativamente significativa con eruzioni di forza sociale qualitativamente importanti, affermando una netta indisponibilità al comando e alla paura come forme di governo. Da settembre a oggi, il movimento del “Blocchiamo tutto” ha attestato la sua capacità di riconvocarsi laddove ha individuato la possibilità di agire concretamente, disertando i palcoscenici ed “esplodendo” laddove si sono sviluppate proficue sincronizzazioni tra realtà organizzate e “sentimenti” diffusi socialmente.
Non è questo il luogo per approfondire un’analisi di come si sia definito il rapporto tra “l’evento” di inizio autunno e i processi che l’hanno reso possibile e che rimangono aperti. Di certo le novità di quella “rivolta” dovrebbero essere prese sul serio. Quel “blocchiamo tutto” è stato invece visto talvolta quasi con fastidio, come un’anomalia, un’irruzione episodica, e ora si torna a quel che si stava facendo prima. Oppure è stato quasi letto come il prodotto lineare di forme organizzate pre-esistenti. Non siamo riuscite, in senso generale, a produrre a caldo un’assemblea nazionale, un momento di confronto, elaborazione e rilancio del movimento nel corso dell’autunno. È stato un evidente limite politico. Da quel vuoto si sono definite varie ipotesi in questi mesi, da quella della coalizione a quella prettamente elettorialistica, dal rilancio di una nuova Flottilla a terreni di gioco “necessari” anche se non scelti come quello della difesa rispetto agli spazi sociali. Stiamo dunque uscendo dall’inverno con un’agenda di lotta primaverile che è importante, ma che rischia di replicare uno schema già visto: una successione di singoli pezzi (tutti fondamentali!) che però non riesce a produrre un’ondata sociale e un’opzione politica complessiva ma solo una serie di iniziative – dal 5 marzo studentesco contro la guerra allo sciopero transfemminista, dal 28 marzo romano alla Flottilla, dal 25 aprile al Primo maggio, alle varie mobilitazioni internazionaliste, etc.
Di fronte a queste domande ed esigenze pensiamo sia importante l’apertura di un cantiere di elaborazione politica su come poter strutturare un’opzione autonoma, cercando un nuovo salto in avanti. Possiamo finalmente lasciarci alle spalle il piangersi addosso del “non sta succedendo niente” o la romanticizzazione di passate epoche di movimento. È un momento storico denso di possibilità, in cui la crisi che attraversiamo nel formulare proposte politiche complessive ed efficaci può essere guardata come una crisi di crescita: delle militanze, delle forme aggregative, della territorializzazione, del raggio d’azione, delle possibilità di rottura. Una crisi che, evidentemente, non garantisce esiti positivi di per sé. Serve insieme pazienza strategica e capacità di uscire dalle comfort zone militanti, rompendo routine e automatismi. Il pensiero strategico nasce da questa frizione: tra immediato e lungo periodo, tra lotte situate e orizzonte di liberazione, tra piano sociale e piano politico.
Oggi un “agire rivoluzionario” va inventato per le nostre latitudini, dentro un’Europa che si periferizza sempre più. Paradossalmente, proprio questa perdita di centralità potrebbe aprire possibilità di rottura inedite. È un’ipotesi da esplorare, non una certezza. Quello che ci sembra necessario è ripensare con forza il tema del conflitto e dell’autonomia. Autonomia è conflitto, così come la ricerca del conflitto va tenuta insieme alla costruzione di autonomia. Non come alternative, ma come tensione permanente tra accumulazione di forza e scontro con le controparti. Se la crisi che attraversiamo, come “noi” inteso in senso ampio, è crisi di crescita, ciò richiede trasformazione. Lasciando alle spalle modalità organizzative del passato, e provando ad assumere il punto di vista della lotta di classe nel non chiedersi solo cosa è possibile ottenere con il nostro agire, ma anche cosa è necessario colpire. Il criterio non è l’inclusività, ma l’efficacia. Non la rappresentanza, ma l’aumento reale dei rapporti di forza.
I centri sociali, le assemblee permanenti, i rituali militanti hanno prodotto in passato identità e attivazione sociale, ma oggi tendono a ristagnare nella propria inerzia. Lontano dall’autoreferenzialità e dalla riproduzione dei singoli collettivi, l’autonomia non è uno spazio, né una tradizione da difendere: è una pratica di rottura che vive solo se si sposta, se attraversa, se organizzandosi disorganizza il campo nemico. Su questo pensiamo che sia necessario anche cominciare a sperimentare nuove modalità di stare nel terreno di battaglia della comunicazione, dentro e contro le piattaforme digitali e gli attuali sistemi informativi, ma anche sviluppando infrastrutture autonome. E cercando di “guardarci dall’esterno” rispetto a quello che stiamo “proponendo” con il nostro agire. Quello che oggi “manca” è una capacità di parlare anche di una condizione economica che da anni vede aumentare l’impoverimento generalizzato, la proletarizzazione, ma senza trovare voci o risposte che sul “caro-vita” propongano iniziative di lotta. Lo sviluppo di contropotere rispetto all’impoverimento, il conflitto sulla riproduzione sociale, sui tagli alla sanità, sulle espulsioni urbane, su quello che in termini sloganistici possiamo chiamare welfare vs warfare, ci pare un terreno strategico da immaginare.
3. Proposte di lotta
Il nostro nodo di fondo.Il rischio che abbiamo di fronte, dopo la “sollevazione” che abbiamo alle spalle, è un ritorno alle piccole rivendicazioni, slegate da un orizzonte di trasformazione generale. Il problema centrale resta il legame materiale tra: lotte situate e territoriali – dimensione internazionale della fase – costruzione di un orizzonte complessivo di rottura. Assumere il punto di vista della lotta di classe, e non quello del governo, delle compatibilità o della gestione dell’esistente, è una linea di demarcazione. Questo non significa che le lotte sociali siano sufficienti a organizzare la rottura politica. Ma nemmeno l’inverso, che basti una dimensione politica senza dinamica sociale. Va ripensato il “rapporto” tra autonomia di classe e autonomia del politico. Di nuovo, senza scorciatoie possibili.
Chi siamo e come agiamo?La domanda sull’agire riguarda direttamente la nostra identità politica. L’identità non è un qualcosa che si disegna a tavolino: è quel che si fa e come questa azione viene socialmente percepita che definisce l’identità politica, non altro. Non La proposta Sul movimento, ma Una proposta Nel movimento, né con la pretesa di dover essere l’unica né con l’arroganza di dover essere imposta da fuori. Lo accennavamo già prima, l’autonomia va pensata come pratica materiale e conflittuale, come postura e non dottrina: l’unica invarianza tracciabile nella prassi autonoma è l’attestazione della variabilità storica intrinseca a ogni terreno di conflitto e, di conseguenza, l’attestazione della necessità sempre presente di innovarsi, superarsi, sperimentare per essere all’altezza di lotte e soggetti sempre in divenire. L’obiettivo è misurarsi realmente con i rapporti di forza, ponendo il problema della politica di massa, di un’opzione politica credibile perché radicata ed efficace – evitando tanto l’autoreferenzialità quanto l’illusione della rappresentanza (non solo in senso elettorale, ma anche “di movimento”). La rappresentanza va rotta, non occupata.
Cosa possiamo apprendere dal Blocchiamo Tutto? Tra le varie cose, ci insegna che contano le risonanze, le scintille, gli “artifici politici”: dispositivi che vanno disegnati sapendo che dovranno essere rotti, superati, rilanciati. In questo orizzonte, proporre dei campi di intervento, per come li abbiamo mappati sinora, significa almeno lavorare su:
- Territorialità: agire metropolitano, spazi, conflitto abitativo e lotta per la casa;
- Dimensione giovanile: scuola, università, quartieri, nuove generazioni;
- Comunicazione: come campo di battaglia e non solo come supporto;
- Riconoscibilità e organizzazione: forme, livelli, articolazioni;
- Reddito/lavoro: come terreno di conflitto e di rottura, non di mediazione;
- Lotta alla guerra: contrapposizione al riarmo e al disciplinamento, internazionalismo.
Il problema non è che le lotte siano troppo concrete, ma che siano innocue: assorbibili, negoziabili, traducibili nel linguaggio della governance. Quando la lotta perde il suo nesso con un orizzonte generale, smette di essere pericolosa e rischia di diventare amministrazione del danno. Rendere praticabile la rottura significa cambiare come stiamo nei conflitti. Non significa una postura purista delle lotte, né il rifiutare che esistano piani tattici che implicano spesso la necessità che singole lotte sedimentino risultati parziali. Ma questi, evidentemente, devono funzionare come accumulo per nuovi rilanci, non come obiettivi in sé stessi.
Alcune note veloci sui primi due precedenti punti. Territorialità non significa presidio, ma capacità di rendere ingovernabile, o quantomeno contendibile, un territorio. Tramontata da tempo la stagione dei centri sociali, sugli spazi la sfida che abbiamo davanti è come rendere politicamente efficace un “salto di scala”, anche a partire dalla spregiudicatezza degli attacchi che il nemico pone su questo ambito. La nostra nuova territorialità non può coincidere con una sequenza di spazi autogestiti come fine in sé, ma deve articolarsi su scala metropolitana più ampia. Qui la sfida, di immaginazione e di pratica politica.
La lotta per la casa (e le lotte “sui bisogni” in generale) si muove sempre su una linea sottile e ambivalente, tra potenziale politico e rischio di mero assistenzialismo. La casa, come orizzonte, non è un diritto da rivendicare, è un terreno da strappare al comando capitalistico. Sulla casa, come possiamo non ridurci a una contesa coi servizi sociali, a un conflitto solo sul piano “micro”? Cosa vuol dire passare dalla difesa caso per caso nell’antisfratto a una campagna permanente contro la rendita: mappare pubblicamente fondi e grandi proprietari, legare occupazioni e sfratti a nomi di piattaforme e grandi proprietari, flussi finanziari, politiche urbane; usare le occupazioni come nodi politici aperti, attraversabili, capaci di parlare alla città; praticare autoriduzioni e forme di sabotaggio sociale che rendano la rendita instabile e costosa.
Nei quartieri, una pratica che sostituisce il welfare senza produrre conflitto rischia di finire per essere un regalo allo Stato. Il mutuo appoggio senza rottura rischia di diventare pacificazione. La questione non è “aiutare”, ma organizzare rabbia, tempo, bisogni contro i dispositivi di controllo, polizia, debito, rendita urbana. Non vuol dire aprire spazi come servizi ma come basi organizzative: luoghi dove casa, cura, reddito, tempo di vita vengono tenuti insieme. Costruire campagne contro dispositivi specifici di comando – sulla riproduzione, sulla repressione poliziale, su grandi opere, logistica urbana etc. – e pratiche solidaristiche che aumentino la capacità di conflitto, non che lo sostituiscano.
Scuole e università non sono bacini da mobilitare ciclicamente, ma macchine di produzione di soggettività docili, precarietà e guerra. Se la lotta qui resta confinata allo “studentismo”, è già persa. L’obiettivo non è migliorare l’istituzione, ma renderla attraversabile dal conflitto: rompere la separazione tra studenti, lavoratori, territori e produzione di sapere. Si tratta di agire “sui bordi” di scuole e università, costruire conflitti che partano dalle frizioni tra istituti formativi e vita materiale: lavoro povero, affitti, trasporti, precarietà.
Un capitolo a parte meritano l’analisi e le scommesse politiche sulla soggettività e la composizione di classe. Quando si aprono ambiti di intervento, infatti, non possiamo che basarci sull’inchiesta coi “soggetti” assieme ai quali ci proponiamo di lottare. Dobbiamo muoverci tra le “contraddizioni strutturali” e il potenziale soggettivo di conflitto. E ogni lotta dovrebbe sempre porsi la prospettiva della generalizzazione possibile, non della “difesa categoriale” (qui la differenza tra una prospettiva sindacale riformista e le forme del “sindacalismo rivoluzionario”) – giusto per fare un esempio. Capacità di parlare a soggettività non già politicizzate, agire su molteplici linee di oppressione e rivolta. È questo un punto evidentemente decisivo, ma per il quale ci sarà bisogno di altro spazio e altri approfondimenti.
In questa fase di possibilità e trasformazioni, serve un tempo politico condiviso capace di farci mettere in discussione vecchi schemi, automatismi, compartimentazioni, producendo una proposta riconoscibile, non una sommatoria. L’obiettivo non è durare, ma incidere. Se si finisse per accettare che autonomia e conflitto siano separabili, si continuerebbe a oscillare tra gestione del poco e fiammate inconcludenti. La crisi, dell’almeno ultimo decennio, di un’opzione politica autonoma tangibile e credibile, non è un incidente: è il segnale che forme, linguaggi e organizzazioni vanno trasformati. Non per nostalgia del vecchio o per nuovismo, ma per necessità storica.
Postilla “sul lavoro”
Intelligenza artificiale, piattaforme, Big Tech e digitalizzazione stanno rivoluzionando i mondi del lavoro (inteso come produzione, riproduzione e circolazione). Come possiamo riprendere in mano in modo nuovo questo tema? Riprendere la questione del tempo di lavoro significa tornare alla domanda: cos’è un programma comunista oggi? Eliminare il lavoro sfruttato non vuol dire smettere di produrre o tornare a comunità ideali, ma trasformare radicalmente la produzione, che non è solo produzione di merci, bensì produzione sociale: di società, di mondo, di vita. Il tempo di lavoro è una scelta politica: è il modo in cui una società distribuisce tempo, ricchezza, potere. Società schiavistiche, fordiste, neoliberali hanno organizzato diversamente questa relazione.
I mille miliardi di Musk non cadono dal cielo, sono ogni ora passata a smontare palchi, far funzionare macchine nei magazzini, curare, alimentare infrastrutture e piattaforme coi nostri dati (ossia: tempo di lavoro). Qui si apre la contraddizione classica, ancora attuale, tra forze produttive e rapporti di produzione. È proprio da qui che una proposta politica autonoma e comunista può tornare ad avere spessore strategico. Oltre alla necessaria critica all’estrattivismo e al colonialismo digitale, è necessario riprendere anche il punto di vista operaista sulla cooperazione sociale e sul general intellect che sta dietro a questo nuovo mondo.
Un programma comunista oggi non è una piattaforma politica, ma una posizione di arrembaggio, di scontro, di battaglia: abolire il lavoro salariato come rapporto sociale e riprendere la produzione di società, conflitto e autonomia. I miliardi accumulati dal capitale tecnologico sono tempo di vita rubato. Questa non è una metafora, è il punto materiale da cui ricominciare a fare paura.
Riprendere il tema del tempo di lavoro significa rendere visibile ciò che tiene insieme tutte le lotte: ogni ora sottratta al salario, alla rendita, al comando è tempo restituito alla vita collettiva. È anche su questo terreno che una pratica autonoma può tornare ad avere un senso strategico e una capacità reale di rottura.
Laboratorio Crash!, Bologna, febbraio 2026