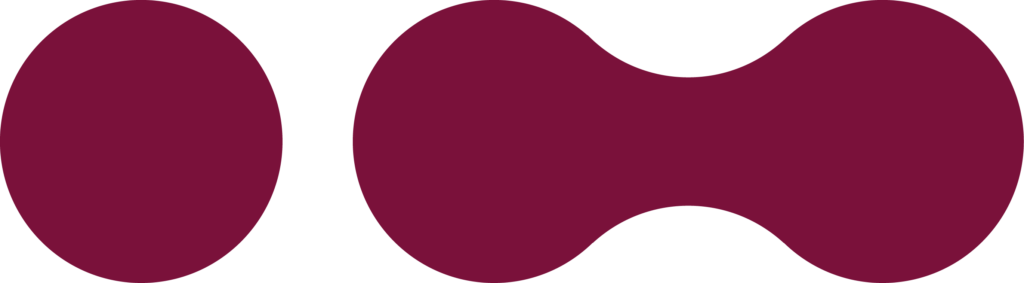C’è una parola che negli ultimi anni è riuscita a portare alla ribalta il suprematismo bianco a livello mondiale tra talk show, programmi politici e discorsi elettorali: remigrazione. A sentirla così, potrebbe sembrare un termine tecnico, quasi amministrativo, e per questo funziona, perché burocratizza la macchina infernale della pulizia etnica. Nella pratica, l’intento è quello di deportare milioni di persone considerate “non appartenenti” ad una presunta identità territoriale.
Dietro questa direttiva si muove una rete ideologica che ormai travalica i confini nazionali. Una vera e propria “internazionale nera”, fatta di partiti sovranisti, movimenti xenofobi, think tank ultra-conservatori e influencer che condividono un immaginario comune: l’idea che l’Occidente sia sotto “invasione”, che esista una sostituzione etnica in atto, che la mescolanza culturale sia una minaccia mortale. E’ qui che la remigrazione diventa il rimedio finale, e la riconquista – altro termine che gli viene accostato – l’ossessione del ritorno a un chissà quale passato glorioso e mitologico. Un asse cresciuto con una temporalità quantomeno decennale, tramite accordi e strategie condivise a livello planetario. In Italia, ma anche più in generale, possiamo registrare un decisivo salto di qualità intorno al 2015, durante la cosiddetta “crisi dei rifugiati” che vide l’exploit della prima ondata d’odio salviniana, con gli hashtag di #stopivasione e #acasaloro. La desecretazione degli Epstein Files avvenuta solo pochi giorni fa, attesta come proprio durante l’ascesa della Lega che portò poi Salvini a co-costruire un governo nel 2018 e nuovamente nel 2019, quest’ultimo abbia intrattenuto un solido rapporto con Stave Bannon – l’ideologo del Make American Great Again – col fine di costruire un progetto suprematista di ambizioni internazionali.
Oggi, a qualche anno dall’ondata dei populismi con cui si chiuse il pre-pandemia, lo spirale di guerra e militarizzazione rappresenta un’occasione imperdibile per imporre la persecuzione tra poveri come architrave di stabilità interna, mentre si armano i fronti esterni. Se da un lato si varano leggi di bilancio paragonabili a carestie medievali, scientificamente prodotte spostando qualsiasi fondo del welfare state su apparati dell’esercito, ecco che dall’altro si proclama la caccia al maranza, all’attivista, all’irregolare (inteso nella sua accezione più ampia): that’s it. Se dividessimo l’internazionale nera dall’escalation bellica, infatti, non potremmo comprendere né la capacità di radicamento che in qualsiasi caso va attestata a tale spregevole piattaforma, né le possibilità che pur esistono di ribaltare questo tabellone di gioco conquistando un mondo radicalmente diverso. La remigrazione non è il “semplice” slogan di destra atto a pretendere una politica migratoria più severa, è una pratica concreta per la ridefinizione di chi detenga o meno il diritto di esistenza in un determinato territorio: è la logica del genocidio in Palestina che si fa globale. Pubblicamente non si usa quasi mai il linguaggio della violenza esplicita, ma si costruiscono con costanza le condizioni culturali per legittimarla e fomentarla: stiamo assistendo a una saldatura tra partiti di estrema destra capaci di raccogliere consenso attorno alle proprie politiche d’odio tanto da vincere elezioni, e milizie informali composte da bande stradaiole che si pongono l’obiettivo di mettere in atto la remigrazione tramite ronde, intimidazioni, pestaggi.
A fronte della portata di questo fenomeno, resistere si presenta come un campo della lotta necessario e insufficiente al tempo stesso. Necessario, perché qualsiasi soggettività dissidente all’interno di questo disegno di apartheid deve affermare con tenacia il proprio diritto di esistenza, insufficiente, perché non esiste un vecchio mondo da tutelare contro pericoli nuovi. E’ la marcescenza proprio di quel mondo lì, con la guerra innalzata a suo sintomo più evidente, che ha reso possibile il suprematismo come ipotesi politica. Nominare la remigrazione per quello che è: ovvero una grigia burocrazia di morte, atta a intrecciare esperimenti di fascismo. Non la macchiettistica riproposizione di connotati vecchi di un secolo, ma un progetto nato nel presente per il presente, nato dalla congiuntura di guerra per la radicalizzazione dei fronti di guerra, interni o esterni che siano.
Resistere laddove siamo chiamate a farlo, ma non in uno sfiancante inseguimento: provando a determinare anche noi un terreno di confronto senza dover assumere unicamente quello del nemico. Risignificare antifascismo e partigianeria come pratiche radicali e di massa, in quella che può sussistere solo come battaglia tra mondi. Essere partigiane, cioè resistere e avanzare insieme, costruendo una nostra parte.